Qualche giorno fa, in mezzo alle montagne dell’Appennino Umbro-Marchigiano, complice il clima estivo, si è ritrovato un gruppo di studenti infermieri, dopo 40 anni dal diploma conseguito il 2 luglio del 1982. Una rimpatriata non scontata in quanto in quattro decenni può accadere di tutto, rischiando di perdere, giocoforza, qualcuno per strada. Così non è stato, per fortuna di tutti, anche se dei 21 studenti della triennale di Infermiere Professionale 1979–1982, eravamo presenti, per vari motivi, in 13. È stato un bell’incontro, utile a ripensare a noi, ai giorni vissuti, al tempo passato come icona di una professione che, forse, abbiamo creduto, presuntuosamente, nascesse proprio allora, in quanto appena quattro anni prima, nel 1975, la scuola era passata da due a tre anni (L. 867/75).
Ricordi di quarant’anni di lavoro infermieristico

Infermieri si incontrano dopo 40 anni

Noi siamo stati, forse, una delle ultime generazioni che ha imparato a fare la terapia parenterale con le siringhe di vetro
Quei tre anni contribuirono a maturarci, non tanto in fretta, ma alacremente di sicuro. I tempi delle scuole regionali erano serrati, in alcuni casi erano già strutturate come un corso universitario: lezioni ed esami al termine.
In altri continuavano a somigliare ad una scuola superiore: quadrimestri, interrogazioni, scrutini e così via.
Alcune materie te le portavi fino all’ultimo giorno di corso: anatomia, patologia, igiene, tecnica infermieristica.
Altre neanche sono più previste in tutti gli attuali programmi, come nel caso di fisica e biofisica che, ad ogni modo, un aiutino contribuirono a darlo alla comprensione del mondo sanitario.
Le lezioni e il tirocinio, dal lunedì al venerdì, occupavano tutta la giornata, dall’alba al tramonto; non contando poi quando si lavorava di notte.
Fummo ammessi in 37, dopo una prova selettiva psico-attitudinale, alla Scuola per Infermieri Professionali di Jesi, in provincia di Ancona. Dopo poco più di otto mesi eravamo già rimasti in 19 e l’anno successivo se ne sarebbero aggiunte altre due per diventare quel totale di 21 studenti che alla fine arrivò al diploma.
Nel corso dell’incontro citato i ricordi sono stati di vario tipo: quelli legati alla scuola, inevitabilmente e quelli propri del lungo percorso di lavoro arrivato, per almeno sei di noi, al traguardo pensionistico.
I ricordi della scuola hanno riguardato lo studio di materie che per molti erano abbastanza difficili, zeppe di parole complicate, facilmente storpiabili: ateleptasia, vitamina C reattiva, termoclisi, e così via.
C’erano gli insegnanti che non amavano essere interrotti e fornivano chiarimenti solo negli ultimi cinque minuti di lezione, praticamente inutili, a fronte di due ore di enunciati fatti di formule, parole sbiascicate e voli pindarici utili più a colmare le deficienze pedagogiche dei docenti che non a sostenere l’apprendimento dei discenti.
C’era poi il solito professore che faceva il cascamorto con qualche studentessa e, se era medico, te lo ritrovavi pure insieme a qualche altro lumacone nei reparti dove andavi a fare tirocinio. Su tutto, la disciplina regnava sovrana. Più di maniera che di sostanza, come tutte le discipline, poco funzionale alla pedagogia ed espressione residuale di un mondo militare molto prossimo a quello sanitario, ma altrettanto lontano da quello assistenziale.
Portavamo il copricapo, cuffia o berretto, ed i capelli dovevano essere rigidamente corti o raccolti; fatto non immediato per i maschietti che venivano dalla stagione ribellistica degli anni ’70. Barba fatta, trucco assente, smalto, gioielli, anelli e bigiotteria varia proibiti, come e comunque. Qualcuno provava a chiedere: Ma se portiamo il copricapo per motivi igienici, perché i medici non lo portano anche loro?
In seguito, avremmo registrato l’abbandono delle cuffie come una grande speranza di cambiamento del mondo sanitario, al pari dell’arrivo dei presidi monouso. Già, il monouso.
Noi siamo stati, forse, una delle ultime generazioni che ha imparato a fare la terapia parenterale con le siringhe di vetro. Ci insegnarono a prendere sterilmente gli aghi, con le pinze, dalla spazzetta, e a raccordarli al cono di vetro di siringhe talmente usate che non si vedeva più neanche la gradazione dei millilitri. Aghi che i vecchi del mestiere ci insegnarono ad affilarli tra una mattonella e l’altra. Lasciamo immaginare i risultati al momento di praticare un’endovena o un’intramuscolo.
Imparammo a sopportare gli odori dell’ospedale e della sofferenza, la vista del sangue e di molto altro. Per qualcuno non fu facile, per altri, che venivano da famiglie operaie o contadine, da quartieri periferici e case popolari, non era poi una così grande novità. Durante la rimpatriata non si è parlato poi tanto delle singole carriere professionali di ognuno di noi.
Sì, qualcuno è diventato coordinatore o addirittura dirigente in una struttura residenziale, ma niente di eccezionale ed i ricordi di quarant’anni di lavoro infermieristico, nonostante reparti e ospedali diversi, alla fine, hanno mostrato un identico quadro di vita.
Storie di colleghi e di conflittualità, pressochè quotidiane, specie con i medici. Quello che faceva il simpatico e ti diceva di dargli tranquillamente del “Tu”, per poi riprendere, a suo piacimento, in mano il suo ruolo gerarchico e trattarti a pesci in faccia alla prima difficoltà. A chi non è capitato il solito Medico di Guardia che di notte faceva mille storie se lo chiamavi e quello che, dopo un’intera mattinata passata a farsi i fatti suoi, ti ordinava mille prestazioni da assolvere nell’ultima ora del turno.
Nella narrazione c’è stato chi ha sottolineato, specie quelli che già si sono ritirati dal lavoro, di non sentirsi più considerati in alcun modo dal sistema. Di essere diventati degli ex-infermieri, spremuti al massimo e poi gettati via, nel dimenticatoio di tutti i lavoratori dipendenti. Nessuno di noi si è lamentato però di essere stato “demansionato”, termine avulso, quanto falso per la nostra generazione.
Piuttosto, al pari dei medici, i soggetti verso cui spesso qualche chiacchiera evocativa si è indirizzata, non in termini lusinghieri, sono stati anche gli stessi dirigenti infermieristici, registrati come più preoccupati di assolvere alla “mission” aziendale che non di rispettare la dignità professionale del singolo, o i bisogni di salute compressi dalle consuete strategie di risparmio dei costi della sanità.
Infermieri nati negli anni dell’utopia del welfare
Già l’azienda. La nostra generazione, quella dei boomer, che ancora oggi rappresenta circa il 25% degli infermieri in servizio, è nata negli anni dell’utopia del welfare. Abbiamo iniziato ad andare a tirocinio nello stesso anno che prendevano il via le USL, nate dalla riforma del 1978, che instituì il Servizio sanitario nazionale. Siamo passati poi per le vane e vacue proposizioni dell’aziendalizzazione, per ritrovarci, a fine carriera, con la metà degli ospedali, dove avevamo tutti lavorato, praticamente chiusi o riconvertiti, o ceduti ai privati.
Vero è che pochi di noi hanno lottato per difendere la sanità pubblica e l’offerta universalista ed equa di assistenza e di sostegno alla salute collettiva. Ma lottare non è facile e bisogna saperlo fare. E poi non si è stati certo con le mani in mano. E mi riferisco sia a noi 21 diplomati dell’82, sia ai tanti altri colleghi di quel tempo, sparsi per il Paese. Tutti sono stati troppo impegnati in realtà nella lotta quotidiana, più umana che politica, più professionale che sindacale, di portare avanti sulle loro spalle il sistema, cercando di farlo funzionare al meglio, pensando che la dedizione al lavoro, il mantenimento della qualità del servizio e la preparazione bastassero.
Una bella scelta ed una bella idea, ma che non sono risultate vincenti, consegnandoci ad una visione del futuro più ricca di cupi presagi che di rosei auspici. Tempi che noi probabilmente vivremo da ex-infermieri e da probabili pazienti (inevitabilmente) e che gli studenti di oggi, gli infermieri di domani, saranno costretti a vivere in maniera non meno dura della nostra.
La generazione degli infermieri boomer sperava, specie dopo la chiusura delle scuole per infermieri generici all’inizio degli anni ’80, e la legge sulla straordinaria riqualificazione professionale (L. 243/80), di poter vivere e lavorare in un contesto in cui le differenze e le gerarchie si sarebbero attenuate. Così non è stato e l’offerta infermieristica è stata schiacciata al ribasso, cercando di sostituire il più possibile con gli Oss il personale assistenziale.
Ma questo sarebbe arrivato solo qualche decennio dopo il nostro diploma, per il quale, in quel lontano 1982, non fu certo facile prepararsi visto che fu l’anno dei mondiali in Spagna. Era abbastanza complicato cercare di studiare nelle giornate in cui giocava l’Italia e molte altre squadre che sportivamente andavano seguite. E poi, quando vinceva la nazionale, non si ritornava certo sui libri, ma si passava la serata a festeggiare.
Come fu, del resto, nella nottata dell’11 luglio quando tutta l’Italia festeggiò la vittoria ai mondiali di calcio, la prima dell’età repubblicana, e noi, che scendemmo a festeggiare in strada allora, eravamo già infermieri da poco più di una settimana. Poi ci sarebbe stato poco da festeggiare, già dall’anno successivo arrivò il blocco delle assunzioni negli ospedali (L. 830/83) e per molti il precariato allungò i suoi tempi. Per qualcuno arrivò addirittura un po’ di disoccupazione; non lunga a dire il vero. Il sentore di importanti e profondi cambiamenti era nell’aria, ma come generazione ce ne accorgemmo troppo tardi.
Avevamo iniziato nell’anno dell’ascesa al potere della Thatcher, e ci eravamo poi diplomati quando ancora la Lady di ferro chiudeva le miniere nel Regno Unito e muoveva guerra all'Argetina nelle Falkland. I suoi insegnamenti iper-liberisti avrebbero condizionato tutto il mondo occidentale, e non solo, per tutti i restanti decenni. Ma, come detto, ce ne accorgemmo tardi, troppo impegnati a mantenere in vita il Servizio sanitario nazionale e poco preparati a conquistare o a difendere diritti e garanzie sociali.Quello vissuto qualche giorno fa è stato un lungo e piacevole pomeriggio, e molte altre considerazioni abbiamo fatto, rispetto a quanto scritto, in qualche caso tratteggiato, appena accennato, sottolineato fugacemente o condiviso in silenzio. Cionostante è stato un bel ritrovarsi, senza troppe nostalgie o rimpianti, con un pizzico di amarezza magari, ma di quella che dà un senso alla vita.
Figli di generazioni forti del passato, abbiamo cercato anche noi di fare la nostra parte: nei servizi domiciliari inaugurati negli anni ’90, o nei day hospital e nelle day surgery strutturati in maniera diffusa, negli ambulatori infermieristici attivati o anche nella formazione resa al passo con i tempi.
Non lo abbiamo fatto certamente solo noi, quelli del triennio ‘79–‘82, ma tutta una generazione di professionisti che ha messo l’anima nella sua carriera lavorativa. E di questo speriamo di aver lasciato qualche traccia e qualche eredità, specie in termini metodologici e relazionali. Per il resto, riverbera nell’aria l’eccitazione del primo giorno di tirocinio, la soddisfazione di avere aiutato qualcuno, la consapevolezza di essere stati testimoni e protagonisti del nostro tempo. Insomma, cose normali e quotidiane per chi è infermiere. Per chi fa l’infermiere.







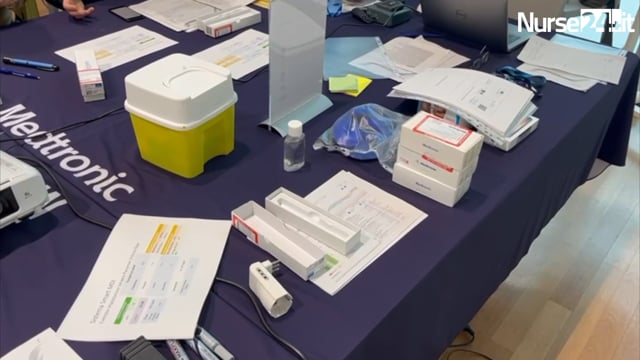











Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?